|
L'INTERVISTA
«Il 7 aprile sventammo un
piano
per sovvertire la democrazia»
Trent’anni dopo il pm
Pietro Calogero rompe il silenzio:
«Si rischiava la guerra civile, non
potevamo aspettare»
di
Antonio Ferrari
Corriere del Veneto,
7 aprile 2009
 PADOVA
— Il 7 aprile del 2009 ha
assai poco in comune con il 7 aprile
di trent’anni fa. Ad accostare le
due date vi sono soltanto la vigilia
pasquale e i capricci meteorologici
della primavera in ritardo. Per il
resto, in questa Padova cresciuta
tumultuosamente, tutto è cambiato.
Le tensioni sociali sono dettate
dall’aggressione della crisi
economica, dall’immigrazione, dal
precariato giovanile. Ma quella
violenza che aveva deturpato la
capitale morale del Veneto non c’è
più: sepolta nei libri di storia e
nella memoria di chi non è più
giovane. Pietro Calogero, 69 anni,
lavora ancora alla procura della
repubblica. Non più in via Altinate,
ma in un nuovo e gigantesco
palazzo, dove la giustizia cammina
lentamente nei suoi lunghi corridoi.
Oggi è un uomo che osserva con
serenità il frutto del suo passato
lavoro. Non vuol sentire parlare di
«teoremi», perché teorema è
un’abusata e denigratoria
qualificazione del lavoro che
questo magistrato ha fatto, con
indubbio coraggio, scoperchiando
molti segreti del terrorismo
italiano di quegli anni. PADOVA
— Il 7 aprile del 2009 ha
assai poco in comune con il 7 aprile
di trent’anni fa. Ad accostare le
due date vi sono soltanto la vigilia
pasquale e i capricci meteorologici
della primavera in ritardo. Per il
resto, in questa Padova cresciuta
tumultuosamente, tutto è cambiato.
Le tensioni sociali sono dettate
dall’aggressione della crisi
economica, dall’immigrazione, dal
precariato giovanile. Ma quella
violenza che aveva deturpato la
capitale morale del Veneto non c’è
più: sepolta nei libri di storia e
nella memoria di chi non è più
giovane. Pietro Calogero, 69 anni,
lavora ancora alla procura della
repubblica. Non più in via Altinate,
ma in un nuovo e gigantesco
palazzo, dove la giustizia cammina
lentamente nei suoi lunghi corridoi.
Oggi è un uomo che osserva con
serenità il frutto del suo passato
lavoro. Non vuol sentire parlare di
«teoremi», perché teorema è
un’abusata e denigratoria
qualificazione del lavoro che
questo magistrato ha fatto, con
indubbio coraggio, scoperchiando
molti segreti del terrorismo
italiano di quegli anni.
Dove eravamo rimasti, dottor
Calogero?
«Alle sentenze che hanno
confermato in sostanza l’impianto
accusatorio. Avevano detto che
cercai di dimostrare che
l’Autonomia Operaia Organizzata e
le Brigate rosse erano la stessa
cosa. Io non l’ho mai detto né mai
pensato. Ho cercato di provare che
tra queste due organizzazioni vi
era un progetto strategico comune:
da una parte l’illegalità di massa,
dall’altra le formazioni combattenti
semiclandestine, e poi quelle
clandestine. La convergenza si
manifestava e si riassumeva nel
«partito armato». Vuole un
paragone? Era come una coalizione di
forze politiche distinte, che
cooperano per lo stesso fine pur
conservando le loro specifiche
individualità. Solo nel Veneto vi
erano stati oltre novecento
attentati. La gente era sconvolta da
tanta violenza. Dopo gli arresti
del 7 aprile, mi sono convinto che
l’impianto terroristico, da quel
giorno in poi, si sarebbe
sgretolato. Come in realtà è
accaduto».
Colpendo, quindi, anche la
facoltà di scienze politiche
dell’università di Padova.
«Non faccio nomi. Mi limito ai
fatti. Alle prove. Di fronte a
episodi criminosi, le indagini
spesso si arenavano nei meandri
della manovalanza e non si poteva
andare oltre. Vede, il ritrovamento
di una pistola era importante, ma a
me interessavano soprattutto i
documenti, perché rispecchiavano la
mano e la mente dei vertici
dell’eversione. Ricordo che per le
violenze alla Fiat, nel 1973, con le
BR che operavano sabotaggi e
devastazioni alle catene di
montaggio, e persino il sequestro
del dirigente Bruno Labate, ci si
arenò su uno scritto apparentemente
senza paternità. Quello scritto,
comparso sulla rivista 'Controinformazione',
organo delle stesse BR, aveva
invece un padre. Che scoprii,
trovando la minuta del documento e
individuando la grafia del suo
autore. A quel punto mi resi conto
che occorreva ribaltare il metodo
delle indagini. Quindi, non partire
dal basso per cercare di arrivare in
alto, ma procedere al contrario,
dall’alto verso il basso. Già nel
’77 avevo avviato un’inchiesta nei
confronti di numerose persone,
molte delle quali furono poi gli
imputati del ’79. Alla fine non se
ne fece niente, perché le prove
furono giudicate inidonee. Ripresi
però il filo delle indagini in
silenzio, fino a quando mi imbattei
nella sorpresa decisiva. Durante
una perquisizione nell’ufficio
dell’architetto padovano Manfredo
Massironi trovammo uno sterminato
archivio. Una preziosa miniera di
carte, documenti, prove. L’archivio
era del professor Antonio Negri, e
il suo ritrovamento lo preoccupò non
poco. Anzi, moltissimo».
A quel punto le indagini, se
ben ricordo, ebbero un’improvvisa
accelerazione.
«Sì. Non soltanto avevo i miei
doveri di magistrato, ma avendo
fede nella verità sentivo di dover
rispondere, anche con la mia
sensibilità di cittadino, ai timori
di una collettività turbata,
spaventata e confusa. Gli elementi
che avevo raccolto indicavano, con
estrema chiarezza, che esisteva un
piano di sovvertimento delle
istituzioni democratiche, volto a
provocare una guerra civile. Non si
poteva più aspettare».
Furono i pentiti ad
indicarle la strada?
«Assolutamente no. Tre testimoni
confermarono quanto già sapevamo.
Ricordo che uno di loro, che aveva
fatto parte di Potere operaio (il
gruppo che poi artificialmente si
autosciolse), venne da me poco dopo
l’assassinio dell’operaio genovese
Guido Rossa, che aveva denunciato
le BR. Il peso che aveva sulla
coscienza quel testimone era
diventato insopportabile, e mi
raccontò tutto. Da magistrato e da
uomo ammiro il coraggio di chi ha
rotto il muro dell’omertà. Le
istituzioni dovrebbero essere
infinitamente grate a chi, per
proteggerle e salvarle, ha messo
davvero a rischio la propria vita».
Perché si parlò del
coinvolgimento di alcuni imputati
nel delitto Moro?
«Un’accusa che non è certo partita
da Padova, né da me. Io, come le ho
detto, avevo trovato le prove,
riconosciute dalle sentenze, del
coordinamento strategico tra
l’Autonomia e altri gruppi armati,
tra cui le BR. Non altro. Le carte
che riguardavano imputazioni mosse
contemporaneamente dai giudici
romani furono inviate nella
capitale».
Però ci sono imputati
dell’inchiesta «7 aprile», come
Emilio Vesce e Luciano Ferrari-Bravo,
che sono stati assolti dopo
svariati anni di carcerazione
preventiva.
«Certo, dispiace sempre, e non poco,
che persone colpite da
provvedimenti restrittivi della
libertà personale, perché accusati
di gravi reati terroristici, siano
assolte nel corso del giudizio dopo
aver subito una troppo lunga
carcerazione preventiva. Ciò è
accaduto non per colpe professionali
dei magistrati ma per alcune
rigidità, proprie del regime
cautelare dell’epoca: in
particolare, i provvedimenti di
cattura nei confronti di dirigenti
e organizzatori di bande armate
eversive dovevano essere emessi
obbligatoriamennte sulla base
dell’esistenza di sufficienti indizi
di colpevolezza; inoltre, per questi
reati, non era consentita, a
differenza di oggi, la concessione
della libertà provvisoria. E’ dunque
avvenuto che solo con la sentenza di
assoluzione (sopraggiunta, per Vesce
e Ferrari-Bravo, al termine del
giudizio di appello, dopo che erano
stati condannati a 14 anni ciascuno
dalla corte d’assise di Roma) gli
imputati assolti hanno potuto
riacquistare la libertà».
E’ sempre convinto che le
indagini che partono dall’alto
siano risolutive, come lo furono
quelle del 7 aprile?
«Il procuratore di Palermo disse al
giudice istruttore Giovanni Falcone
che sarebbe stato utile seguire il
mio metodo. Falcone, che me lo
confidò, rispose che il
suggerimento era prezioso, ma che in
Sicilia il problema era assai
diverso: la mafia non scrive, non
lascia documenti. Il decisivo salto
di qualità delle indagini sulla
cupola si ebbe con le dichiarazioni
di Tommaso Buscetta. Per la prima
volta, dall’interno, e dal suo più
alto livello, si lanciava un fascio
di luce sui segreti di Cosa Nostra.
Per noi, invece, è stato diverso.
La quantità di documenti recuperati
era impressionante. La grafomania di
molti ci ha indubbiamente aiutato».
Ha rimpianti? Rimorsi? Sensi
di colpa?
«Penso di avere fatto soltanto il
mio dovere».
L'anniversario contestato
Terrorismo e 7 aprile padovano.
Non c'è una storia da riscrivere
«Basta con le bugie dei
reduci di Autonomia operaia»
Il Mattino di
Padova,
4 aprile 2009
 In
questi giorni alcuni dirigenti di
quel che resta dell’esperienza
dell’Autonomia Operaia Organizzata
stanno cercando con convegni e
pubblicazioni di accreditare la
teoria che le inchieste della
procura di Padova sul terrorismo
rosso, culminate negli arresti del 7
aprile 1979, sarebbero state il
frutto di una montatura politica e
si sarebbero risolte con le
assoluzioni degli imputati. In
questi giorni alcuni dirigenti di
quel che resta dell’esperienza
dell’Autonomia Operaia Organizzata
stanno cercando con convegni e
pubblicazioni di accreditare la
teoria che le inchieste della
procura di Padova sul terrorismo
rosso, culminate negli arresti del 7
aprile 1979, sarebbero state il
frutto di una montatura politica e
si sarebbero risolte con le
assoluzioni degli imputati.
IL TENTATIVO
Si tratta di un tentativo
patetico e maldestro, sostenuto e
sponsorizzato da qualche gruppo
editoriale e da qualche accademico,
di nascondere e negare le
responsabilità di chi ha commesso
gravi reati e ha promosso
associazioni eversive che hanno
organizzato e realizzato violenze e
crimini per indebolire le
istituzioni e rovesciare
l’ordinamento democratico. E’ il
tentativo di chi sa di essere stato
sconfitto perché è rimasto isolato
nella società.
I reduci dell’Autonomia fingono di
ignorare le verità accertate in sede
giudiziaria, di dimenticare i
crimini e le vittime del terrorismo
e inventano fantasiose teorie per
occultare le responsabilità. Così si
alimentano le versioni di parte,
costruite ad arte dai terroristi e
dai loro seguaci e simpatizzanti per
falsificare e mistificare la realtà.
Nel 1979 avevo 10 anni, non sono
rimasto coinvolto né emotivamente né
personalmente da quelle vicende e
non cerco vendette né accanimenti
giudiziari. Penso che sia sbagliato
dare spazio, credito ed ascolto alle
ricostruzioni storiche degli anni di
piombo basate soltanto sulle
versioni dei terroristi e dei loro
amici. Sarebbe come se la storia
della mafia fosse raccontata da Totò
Riina o quella della Repubblica di
Salò da qualche comandante delle
Brigate Nere. E’ ora di finirla con
l’anomalia solo italiana che
considera i terroristi, autori di
omicidi e violenze, come delle
vittime del sistema giudiziario o
come eroi positivi incompresi dal
sistema.
UN PUNTO FERMO
Innanzitutto bisogna
affermare con forza un punto fermo:
chi difese la democrazia stava dalla
parte della ragione, chi organizzò
l’eversione stava dalla parte del
torto. Chi teorizzò e praticò la
violenza, chi organizzò e militò nei
gruppi armati, chi sparò, chi
attentò alla vita di altre persone
commise dei reati gravi e si macchiò
di crimini da condannare.
Magistrati, forze dell’ordine,
dirigenti e militanti di partiti e
sindacati, cittadini, professori,
giornalisti, tutti coloro che
contrastarono l’eversione e il
terrorismo, difesero le istituzioni
e la democrazia e devono essere
ringraziati e ricordati per il
servizio che resero al Paese.
Per discutere del terrorismo e
degli anni di piombo in modo
obiettivo ritengo necessario partire
dai fatti, dalle vittime, studiare,
conoscere e divulgare le sentenze
che hanno giudicato i responsabili
dei reati e le certezze raggiunte
nei tribunali. Le sentenze
definitive sono state emesse da
diversi anni e hanno individuato
responsabilità e colpe precise per
gli autori di delitti gravissimi
determinando pene consistenti e
contribuendo così a chiudere una
stagione di lutti e violenze.
Al termine del lungo percorso
giudiziario, che ebbe un momento
importante negli arresti del 7
aprile 1979, su 243 persone rinviate
a giudizio, 162 furono condannate a
424 anni e 2 mesi di reclusione, e
la pena fu ridotta dalle amnistie,
dalle prescrizioni e dall’ampia
concessione delle attenuanti.
Inoltre le sentenze confermarono
l’esistenza del partito armato,
fondato sui rapporti politici e
militari tra diversi gruppi
terroristici: Brigate Rosse, Prima
Linea, Autonomia Operaia
Organizzata, Collettivi Politici
Veneti. Queste organizzazioni erano
collegate e coordinate nelle loro
azioni e utilizzavano la violenza
armata per realizzare lo stesso
disegno eversivo di destabilizzare e
colpire le istituzioni.
IL LAVORO DI CALOGERO
Il lavoro coordinato dal
dottor Pietro Calogero portò alla
luce per la prima volta la struttura
organizzativa del partito armato che
era articolato su due livelli: il
fronte di massa e il fronte
combattente. Il primo praticava la
violenza diffusa e l’illegalità di
massa; il secondo realizzava azioni
armate contro obiettivi specifici. A
Padova furono assassinati Graziano
Giralucci, Giuseppe Mazzola,
militanti del Msi, e l’agente di
polizia Antonio Niedda, furono
feriti con colpi d’arma da fuoco il
giornalista Antonio Garzotto, il
professor Ezio Riondato, Giampaolo
Mercanzin, il professor Angelo
Ventura, dopo essere stato ferito,
sfuggì ad un agguato omicida solo
grazie ad una sua tempestiva
reazione, i professori Guido Petter
e Oddone Longo furono selvaggiamente
picchiati. Ci furono aggressioni e
violenze contro chi si opponeva agli
autonomi, ci furono attentati
incendiari ed esplosivi. Per anni,
grazie ad una sostanziale impunità,
Padova diventò il centro del
terrorismo e della violenza diffusi.
Le teorie dei reduci dell’Autonomia
Operaia non spiegano e non dicono
chi organizzò e realizzò questa mole
impressionante di crimini, non
dicono chi furono i responsabili di
omicidi e violenze. Le prove
raccolte dalle forze dell’ordine e
dai magistrati padovani invece
riuscirono ad individuare molti
colpevoli e a farli condannare con
sentenze definitive in tribunale.
Senza quelle inchieste e senza gli
arresti del 7 aprile 1979 il
terrorismo non sarebbe stato
sconfitto.
LE RESPONSABILITA’
Pietro Calogero fu il
primo a comprendere le
caratteristiche del partito armato;
le sue indagini accertarono le
responsabilità per reati specifici e
scardinarono l’impostazione
strategica della lotta armata. Non a
caso i processi si sono conclusi con
sentenze di condanna. Per questo i
reduci dell’Autonomia odiano il
teorema Calogero, perché sanno che è
stato dimostrato in sede
giudiziaria: l’unica valida in un
sistema democratico per accertare le
responsabilità penali; e sanno che
proprio le prove raccolte dalla
Procura di Padova individuarono gli
autori di terribili reati e
assestarono un colpo decisivo contro
il terrorismo. I reduci
dell’Autonomia si preoccupano se
sentono parlare delle sentenze,
temono il ricordo documentato di
quegli anni, perché sono infastiditi
dalla memoria delle responsabilità
dei crimini commessi. Solo così si
spiegano l’ostinazione e la
pervicacia con le quali continuano a
raccontare bugie su quel periodo.
VERITA’ ROVESCIATA
Da tempo molte persone che
hanno diretto e sostenuto
l’eversione e la lotta armata
lavorano per rovesciare le evidenze
e le verità accertate nei processi.
Purtroppo questo lavoro è stato
favorito da chi in passato ha
collaborato con le organizzazioni
terroristiche e ne ha condiviso le
strategie e le finalità senza però
essere condannato. Molti di questi
soggetti sono riusciti a sfuggire
alle condanne per i ritardi e le
inefficienze del sistema giudiziario
o sono stati assolti per
insufficienza di prove e ricoprono
ora ruoli importanti nel mondo
universitario e negli organi di
informazione. A questo lavoro si è
aggiunta una responsabilità delle
istituzioni che, per anni, fino
all’approvazione della legge del
2007 che ha istituito il giorno
della memoria delle vittime del
terrorismo, hanno considerato
l’eversione una parentesi da
chiudere in fretta, anche per
coprire le incapacità e le iniziali
complicità di alcuni settori dello
Stato. Per queste ragioni i
terroristi e i loro sostenitori,
fiancheggiatori e amici, hanno
svolto e, almeno in parte,
continuano a svolgere un ruolo di
protagonisti nelle ricostruzioni di
quel periodo.
IL CONVEGNO
Ecco perché si organizzano
convegni sul 7 aprile senza parlare
dei fatti, delle vittime, dei 708
atti di violenza eversiva commessi a
Padova soltanto tra il 1977 e il
1979. Ecco perché si parla troppo
poco di chi ebbe il coraggio,
mettendo a repentaglio la propria
vita, di contrastare la violenza
politica. Ed ecco perché se qualcuno
ricorda i fatti e le vittime, se
ricostruisce le vicende sulla base
delle sentenze definitive, se
elenca, con nomi e cognomi, in modo
trasparente, i criminali
responsabili di gravi reati e
violenze contro cose e persone viene
subito attaccato ed accusato delle
peggiori infamie.
Penso che ricordare la verità
storica sia un preciso dovere civile
e morale, in particolare nei
confronti di chi ha perso la vita ed
è stato vittima dei terroristi e nei
confronti delle giovani generazioni
che rischiano di crescere in un
vuoto di memoria pericolosissimo,
perché in quel vuoto possono
attecchire di nuovo ideologie e
pratiche violente e teorie eversive
e antidemocratiche.
IL
LIBRO
Gli
anni di piombo e il partito armato
tra Br e Autonomia
Solo nel biennio 1977-79 denunciati
708 atti di violenza:
447 attentati, 132 aggressioni e 129
rapine
Il Mattino
di Padova, 30 novembre 2008
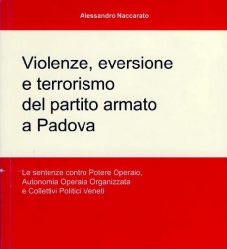 PADOVA.
Un saggio sul partito armato, sulla
violenza di massa, le notti dei
fuochi e il terrore nelle facoltà.
Uno studio non sociologico, ma
costruito con le sentenze passate in
giudicato emesse dai tribunali, che
in Veneto non hanno mai abdicato al
loro ruolo: Padova fu la capitale
del terrorismo diffuso, con
Autonomia Operaia Organizzata e i
Collettivi Politici Veneti che hanno
costruito un record unico in Italia.
Solo nel biennio 1977-79 furono
denunciati 708 atti di violenza
eversiva, con 447 attentati, 132
aggressioni a persone e 129 rapine e
devastazioni. PADOVA.
Un saggio sul partito armato, sulla
violenza di massa, le notti dei
fuochi e il terrore nelle facoltà.
Uno studio non sociologico, ma
costruito con le sentenze passate in
giudicato emesse dai tribunali, che
in Veneto non hanno mai abdicato al
loro ruolo: Padova fu la capitale
del terrorismo diffuso, con
Autonomia Operaia Organizzata e i
Collettivi Politici Veneti che hanno
costruito un record unico in Italia.
Solo nel biennio 1977-79 furono
denunciati 708 atti di violenza
eversiva, con 447 attentati, 132
aggressioni a persone e 129 rapine e
devastazioni.
A tornare su quella stagione è
Alessandro Naccarato, deputato Pd,
che ha annodato i fili della memoria
nel libro ”Violenze, eversione e
terrorismo del partito armato a
Padova” edito da Cleup: 340 pagine
dense di nomi, cronologie e fatti
ricostruiti con le tre sentenze
emesse dal tribunale di Padova e
dalle corti d’Assise di Roma e
Padova.
Naccarato ricostruisce, con
l’approccio del rigore storico, la
galassia dei movimenti e parte da
Potere Operaio e dai suoi leader:
Oreste Scalzone, Franco Piperno e
Toni Negri.
Perché ha scritto un volume
raccogliendo le sentenze: gli anni
di piombo sono storia di 30 anni
fa...
«Perché le sentenze sono una
fonte storica eccezionale: esse sono
il risultato di indagini e processi
e quindi del confronto tra prove
oggettive, testimonianze orali,
documenti scritti, raccolti ed
esposti dalle parti in causa. Tutto
il materiale viene analizzato più
volte nei vari gradi di giudizio, in
tempi differenti e con giurie
formate da diverse persone. Per
questo motivo, per ricostruire le
vicende del Partito Armato a Padova
mi sono basato sulle sentenze emesse
nei tre principali processi. Ne esce
un quadro impressionante, che
riguarda 243 persone rinviate a
giudizio per vicende di terrorismo,
162 delle quali condannate a 424
anni di carcere».
I primi passi chi li mosse?
«Ovviamente Potere Operaio, che
decise di strutturarsi su due
livelli: uno armato, centralizzato,
con strumenti adeguati ad una
strategia di offesa; l’altro di
massa per essere presente nei
movimenti».
Ma il partito armato cos’era:
una galassia di sigle?
«Il partito armato era fondato
sullo stabile collegamento operativo
tra singole distinte organizzazioni,
che erano collegate tra di loro da
rapporti politici e militari: Br,
Prima Linea, Autonomia operaia
organizzata, Collettivi politici
veneti. Queste organizzazioni
agivano in modo complementare e
concorrevano insieme, utilizzando la
violenza armata, nel disegno
eversivo di destabilizzare e colpire
le istituzioni democratiche».
Lei nel suo libro ricorda il
Gruppo Ferretto di Mestre: di cosa
si tratta?
«Il primo salto di qualità
nella strategia eversiva è il patto
tra i Gap di Feltrinelli, le Br e
Pot Op, con la nascita del Gruppo
Ferretto a Mestre. Là, secondo la
testimonianza di un dirigente della
colonna veneta delle Br, Michele
Galati, militarono Carlo Picchiura,
Susanna Ronconi, Pietro Despali, Ivo
De Rossi, Giuseppe Zambon, Massimo
Pavan, Roberto Ferrari e un tale di
Verona soprannominato Sherif, poi
identificato per Martino Serafini.
Esaurita la prima fase, il gruppo
entra nelle Br e rafforza la colonna
veneta costituita nel 1974, la cui
direzione comprendeva Giorgio
Semeria, Prospero Gallinari, Roberto
Ognibene e Fabrizio Pelli.
Il Gruppo Ferretto fu quindi la
prima esperienza di cooperazione tra
militanti di Pot Op e militanti Br
sul terreno della lotta armata».
Qualche mese dopo in via
Zabarella c’è il duplice omicidio
nella sede del Msi...
«Sì, il 17 giugno 1974 Graziano
Giralucci e Giuseppe Mazzola furono
uccisi. Per questi omicidi verranno
in seguito condannati Renato Curcio,
Alberto Franceschini, Mario Moretti,
Giorgio Semeria, Roberto Ognibene,
Martino Serafini e Susanna Ronconi».
Ma quando nasce Autonomia
operaia?
«Le sentenze stabiliscono che
AOO nasce nella IV conferenza
nazionale di Pot Op che si tenne a
Rosolina dal 31 maggio al 3 giugno
1973. Là Antonio Negri esce da
Potere Operaio e promuove tra il 28
luglio e il 4 agosto nella facoltà
di Scienze politiche un seminario
che diede vita alla nuova
organizzazione».
Nel 1974 c’è un altro fatto
decisivo, che vede protagonista
Antonio Negri: qual è?
«Il 5 dicembre ad Argelato di
Ferrara, un commando armato assalta
un furgone portavalori della Siiz,
lo zuccherificio Montesi. Viene
assassinato il brigadiere dei
carabinieri Andrea Lombardini e
ferito l’appuntato Sciarretta. La
sentenza della Corte d’Assise di
Roma condanna Caterina Pilega,
Silvana Marelli e Antonio Negri».
E’ una storia molto controversa,
ma quale fu il ruolo del professore,
poi eletto deputato del Partito
radicale per evitare il carcere?
«No, non è affatto controversa.
La Corte d’Assise individuò in Toni
Negri l’ideatore e il mandante dei
fatti di Argelato sulla base di
diversi elementi: le finalità della
rapina per finanziare
l’organizzazione della quale Negri
era al vertice, le dichiarazioni di
diversi testimoni e il comportamento
del professore dopo il fatto.
Inoltre l’agenda di Negri consentì
di trovare riscontri decisivi ai
racconti dei testimoni. Il filosofo,
subito dopo il fatto, intervenne per
aiutare la fuga degli esecutori
materiali: il 5 dicembre 1974
incaricò Mauro Borromeo di andarli a
prendere alla stazione di Milano e
il giorno successivo partì per la
Svizzera per predisporre
l’accoglienza dei fuggitivi. Quello
stesso giorno Borromeo incontrò
Caterina Pilenga per avvisarla di
tenersi a disposizione. Il 9
dicembre Claudio Bartolini, Stefano
Cavina, Franco Franciosi ed Ermesto
Rinaldi (esecutori materiali della
rapina) furono accompagnati al
confine da Borromeo, Pilenga e
Marelli».
C’è un altro delitto che scuote
Padova...
«Sì, il 4 settembre 1975 Carlo
Picchiura uccise l’agente di polizia
Antonio Niedda a Ponte di Brenta».
C’erano rapporti tra le diverse
organizzazioni terroristiche?
«Sì, è una delle caratteristiche
del partito armato. I legami tra Br
e AOO non si interrompono mai:
nell’inverno ’72-73 a Torino, Renato
Curcio incontra Marco Bellavita,
Negri e Fioroni per approfondire la
situazione della Fiat, poi c’è un
summit con Franceschini ma il
vertice più delicato avviene dopo il
delitto di via Zarabella. Toni Negri
critica l’assalto delle Br e lo
bolla politicamente arretrato. Il
vero obiettivo da colpire è il PCI,
ormai «socialdemocratico».
E a Padova che succede?
«Le sentenze ricostruiscono la
lista infinita delle violenze
dell’Autonomia: dall’assalto al
Portello, con la casa dello studente
Fusinato avamposto di Pot Op e
teatro degli scontri con la polizia
fin dal 9 marzo 1973, alle prime
esercitazioni armate sui Colli
euganei per passare poi alle
violenze all’università. Un elenco
impressionante di minacce e pestaggi
contro i pochi professori che si
opponevano agli autonomi: Guido
Petter, Oddone Longo e tanti altri.
Inoltre ci furono le azioni del
Fronte comunista combattente, una
banda armata degli autonomi, che
sparò al giornalista Antonio
Garzotto, al professor Ezio Riondato
allora presidente della Cassa di
risparmio di Padova e Rovigo, al
direttore dell’Esu Giampaolo
Mercanzin e al professor Angelo
Ventura. In particolare l’attentato
contro Ventura portò alla luce i
rapporti strettissimi tra Br e
gruppi dell’autonomia».
Che senso ha tornare sugli anni
di piombo: non è meglio dimenticare
o perdonare?
«Molte persone che hanno
organizzato la lotta armata agiscono
ancora oggi per nascondere la verità
e smontare le responsabilità
accertate nei processi. Finita
quella stagione è calato un silenzio
assoluto: il terrorismo è stato
considerato una parentesi da
chiudere in fretta, come se ci fosse
la volontà di coprire le incapacità
e forse le complicità di alcuni
apparati dello Stato».
Secondo lei perché?
«Molti interrogativi sono
rimasti senza risposte: i terroristi
godettero di una sostanziale
impunità per anni e i magistrati che
indagarono furono derisi e insultati
dall’opinione pubblica. Oggi molti
protagonisti della lotta armata sono
invitati nelle trasmissioni tv e
raccontano la loro verità anche
dalle cattedre dell’università. E si
tratta di verità completamente
diverse dalle certezze raggiunte con
le sentenze. Il terrorismo va
inquadrato nel contesto storico e
appare evidente l’esistenza di una
cattiva coscienza di alcuni settori
del mondo culturale e accademico che
hanno offerto spazi enormi ai
protagonisti del crimine».
C’è una data che ha segnato la
storia: 7 aprile 1979, il blitz di
Pietro Calogero. Lei che ne pensa?
«Che senza quel blitz il
terrorismo non sarebbe stato
sconfitto. Il dottor Pietro Calogero
fu il primo a comprendere le
caratteristiche del partito armato.
L’inchiesta da lui coordinata
raccolse le prove che accertarono le
responsabilità per fatti specifici e
scardinò l’impostazione strategica
della lotta armata. Per questa
ragione le sentenze definitive hanno
confermato l’impostazione
dell’inchiesta della procura di
Padova e si sono concluse,
contrariamente a quanto si fa
credere ad arte, con le condanne dei
protagonisti dei gruppi eversivi».
Si parlò molto di spontaneismo
armato, di atteggiamenti repressivi
della magistratura, di pentiti
ammaestrati...
«Non è vero che le inchieste
siano nate con il contributo dei
pentiti, ammaestrati dai magistrati.
Le dichiarazioni dei pentiti
contribuirono a ricostruire il
contesto, a confermare le prove
raccolte dagli inquirenti. Le leggi
sui pentiti e sui dissociati sono
state emanate nel 1979 e nel 1982,
insomma quando le inchieste erano di
fatto già concluse. Lo spontaneismo
armato è pura invenzione, la
violenza era frutto di una precisa
organizzazione. E sulla repressione
consiglio di leggere le sentenze:
molti reati furono amnistiati nel
1986, e vennero riconosciute in modo
larghissimo le attenuanti generiche
a molti imputati».
Un libro destinato a riaprire
polemiche: lei che scopo si è
prefisso?
«Uno solo: ricordare come sono
andate davvero le cose. In questi
anni abbiamo assistito al
protagonismo degli ex terroristi e
in troppi si sono dimenticati delle
vittime e di chi ebbe il coraggio,
spesso mettendo a repentaglio la
propria incolumità, di combattere la
violenza politica. Ci sono stati
poliziotti, carabinieri, magistrati,
operai, professori, giornalisti che
sono stati assassinati dai
terroristi: la democrazia è rimasta
in piedi grazie al loro sacrificio.
Ricordare la verità storica è un
preciso dovere civile e morale».
Gli articoli di
Antonio Ferrari sul caso
7
aprile, indagine sulla transizione
Il
ruolo dei cattivi maestri che
ispirarono i terroristi
di Sergio Romano
Corriere
della Sera, 6 aprile 2009
Come altri
drammi degli anni Settanta anche
quello del «7 aprile» è un
canovaccio pieno di sospetti,
illazioni e clamorosi colpi di
scena, continuamente letto e
interpretato secondo gli occhiali
deformanti di coloro che cercarono
di descriverlo. Accanto allo scontro
tra il terrorismo e lo Stato
(magistratura e forze dell' ordine)
vi fu allora la guerra civile delle
dichiarazioni e delle opinioni: un
intruglio di sentimenti, calcoli
politici e riflessi ideologici che
contribuivano a rendere le vicende
ancora più imbrogliate di quanto non
fossero. I giornalisti furono
investiti di grandi responsabilità.
Molti cedettero alla tentazione di
piegare gli avvenimenti alle loro
tesi. Altri trasformarono l' intera
vicenda in un feuilleton «pieno di
sangue e furore». Quando leggo i
loro articoli, trent' anni dopo, ho
l' impressione che siano ingialliti
come la carta dei giornali su cui
vennero stampati. Vedo a occhio nudo
l' imprecisione delle notizie, il
partito preso delle ideologie, la
retorica del «sensazionale». Se devo
servirmene per ricostruire un
avvenimento o collocare i fatti in
una prospettiva storica, comincio
dopo qualche riga a dubitare della
loro credibilità. Esistono anche,
per fortuna, gli articoli di coloro
che stanno ai fatti e cercano di
tenere a bada per quanto possibile
le loro emozioni. Gli articoli che
Antonio Ferrari scrisse da Padova,
in quei giorni, per il Corriere
della Sera, appartengono a questa
terza categoria. Vi è quel tanto di
«colore» che è necessario per
evocare l' ambiente e il contesto.
Vi è il ritmo del dramma con i suoi
numerosi, incalzanti episodi. Vi
sono i personaggi con le loro virtù,
i loro difetti e i loro tic. Ma vi
sono soprattutto i fatti, i giorni e
le ore in cui sono accaduti, le
parole pronunciate dai protagonisti,
i testi essenziali degli atti
ufficiali. È questa la ragione per
cui non sono invecchiati. Possono
essere letti oggi con lo stesso
interesse con cui furono letti
allora. Mentre i magistrati
raccoglievano le prove per i
processi che si sarebbero celebrati
nei mesi seguenti, Ferrari
depositava agli atti il dossier di
cui gli storici avrebbero avuto
bisogno per condurre le loro
indagini. Letto oggi, questo dossier
contiene almeno tre elementi che
trascendono le vicende della cronaca
e danno un senso più chiaro alla
storia italiana di quegli anni. In
primo luogo l' inchiesta del 7
aprile dimostrò che il terrorismo
aveva dei cervelli e che questi
cervelli erano nelle università.
Anche se gli esecutori furono spesso
persone di modesta intelligenza, l'
idea della lotta armata fu concepita
nelle cattedre ancor più che fra i
banchi degli studenti. Non penso
soltanto a Toni Negri e ai suoi
collaboratori. Penso anche a quei
docenti e a quegli intellettuali che
furono testimoni-complici del
fenomeno e fornirono ai militanti i
sofismi di cui avevano bisogno per
perdonare a se stessi la violenza di
cui furono colpevoli. Come abbiamo
constatato nei casi recenti di
Marina Petrella e Cesare Battisti,
questa irresponsabile civetteria
dell' intelligencija esiste ancora e
in qualche caso alberga addirittura
nei palazzi del potere. In secondo
luogo l' inchiesta del 7 aprile fu
un passaggio decisivo nella storia
della magistratura italiana degli
ultimi decenni. I magistrati erano
da tempo in prima fila, sospinti
dalle incertezze e dalle divisioni
con cui la classe politica stava
affrontando i postumi del ' 68 e la
violenza della lotta armata. Avevano
fatto istruttorie difficili e
coraggiose, erano stati minacciati,
rapiti, uccisi. Uno di essi, Emilio
Alessandrini, era stato assassinato
a Milano da un commando di Prima
linea poche settimane prima dell'
inizio dell' operazione di Padova.
Questi rischi, queste responsabilità
e la notorietà che ne fu l'
inevitabile ricaduta, hanno avuto l'
effetto di modificare il ruolo
pubblico dei magistrati, soprattutto
inquirenti. È questo il momento in
cui smettono di essere funzionari
della legge e diventano «salvatori
della patria». L' inchiesta del 7
aprile ebbe l' effetto di accelerare
questa tendenza. Ma ebbe anche l'
effetto di dimostrare che la
magistratura non era meno divisa di
quanto fosse la società italiana e
che era anch' essa malata di
ideologia. Gli articoli di Antonio
Ferrari (raccolti nel volume 7
aprile edito dalla Cleup) sono una
radiografia del palazzo di giustizia
di Padova nei mesi in cui i
protagonismi cominciano a indebolire
l' efficacia dello strumento
giudiziario. La terza constatazione
concerne il Veneto. Costretto a
rincorrere le indagini in alcuni
paesi della provincia di Padova,
Vicenza e Venezia, Ferrari rivela al
lettore disattento una regione
alquanto diversa da quella che
ancora sopravvive nei romanzi e
racconti di Guido Piovene, Goffredo
Parise, Neri Pozza. La
proliferazione degli insediamenti
industriali ha cambiato, insieme al
paesaggio, le abitudini, lo stile di
vita e la cultura delle ultime
generazioni. Come in altri momenti
della storia politica della regione,
la capitale intellettuale di questo
nuovo Veneto è Padova. Ma nelle
antiche aule e nelle gloriose
cattedre del suo Studio vi sono
malauguratamente i cattivi maestri e
i cattivi discepoli. Chi vorrà fare
la storia di questo nuovo Veneto nel
momento della transizione dal
vecchio al nuovo dovrà leggere
queste pagine di Antonio Ferrari.
visita il sito
www.alessandronaccarato.it
mail:
info@alessandronaccarato.it -
tel 049660544 fax 0498753610
|

 PADOVA
— Il 7 aprile del 2009 ha
assai poco in comune con il 7 aprile
di trent’anni fa. Ad accostare le
due date vi sono soltanto la vigilia
pasquale e i capricci meteorologici
della primavera in ritardo. Per il
resto, in questa Padova cresciuta
tumultuosamente, tutto è cambiato.
Le tensioni sociali sono dettate
dall’aggressione della crisi
economica, dall’immigrazione, dal
precariato giovanile. Ma quella
violenza che aveva deturpato la
capitale morale del Veneto non c’è
più: sepolta nei libri di storia e
nella memoria di chi non è più
giovane. Pietro Calogero, 69 anni,
lavora ancora alla procura della
repubblica. Non più in via Altinate,
ma in un nuovo e gigantesco
palazzo, dove la giustizia cammina
lentamente nei suoi lunghi corridoi.
Oggi è un uomo che osserva con
serenità il frutto del suo passato
lavoro. Non vuol sentire parlare di
«teoremi», perché teorema è
un’abusata e denigratoria
qualificazione del lavoro che
questo magistrato ha fatto, con
indubbio coraggio, scoperchiando
molti segreti del terrorismo
italiano di quegli anni.
PADOVA
— Il 7 aprile del 2009 ha
assai poco in comune con il 7 aprile
di trent’anni fa. Ad accostare le
due date vi sono soltanto la vigilia
pasquale e i capricci meteorologici
della primavera in ritardo. Per il
resto, in questa Padova cresciuta
tumultuosamente, tutto è cambiato.
Le tensioni sociali sono dettate
dall’aggressione della crisi
economica, dall’immigrazione, dal
precariato giovanile. Ma quella
violenza che aveva deturpato la
capitale morale del Veneto non c’è
più: sepolta nei libri di storia e
nella memoria di chi non è più
giovane. Pietro Calogero, 69 anni,
lavora ancora alla procura della
repubblica. Non più in via Altinate,
ma in un nuovo e gigantesco
palazzo, dove la giustizia cammina
lentamente nei suoi lunghi corridoi.
Oggi è un uomo che osserva con
serenità il frutto del suo passato
lavoro. Non vuol sentire parlare di
«teoremi», perché teorema è
un’abusata e denigratoria
qualificazione del lavoro che
questo magistrato ha fatto, con
indubbio coraggio, scoperchiando
molti segreti del terrorismo
italiano di quegli anni.
 In
questi giorni alcuni dirigenti di
quel che resta dell’esperienza
dell’Autonomia Operaia Organizzata
stanno cercando con convegni e
pubblicazioni di accreditare la
teoria che le inchieste della
procura di Padova sul terrorismo
rosso, culminate negli arresti del 7
aprile 1979, sarebbero state il
frutto di una montatura politica e
si sarebbero risolte con le
assoluzioni degli imputati.
In
questi giorni alcuni dirigenti di
quel che resta dell’esperienza
dell’Autonomia Operaia Organizzata
stanno cercando con convegni e
pubblicazioni di accreditare la
teoria che le inchieste della
procura di Padova sul terrorismo
rosso, culminate negli arresti del 7
aprile 1979, sarebbero state il
frutto di una montatura politica e
si sarebbero risolte con le
assoluzioni degli imputati.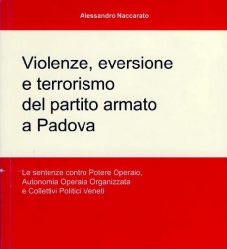 PADOVA.
Un saggio sul partito armato, sulla
violenza di massa, le notti dei
fuochi e il terrore nelle facoltà.
Uno studio non sociologico, ma
costruito con le sentenze passate in
giudicato emesse dai tribunali, che
in Veneto non hanno mai abdicato al
loro ruolo: Padova fu la capitale
del terrorismo diffuso, con
Autonomia Operaia Organizzata e i
Collettivi Politici Veneti che hanno
costruito un record unico in Italia.
Solo nel biennio 1977-79 furono
denunciati 708 atti di violenza
eversiva, con 447 attentati, 132
aggressioni a persone e 129 rapine e
devastazioni.
PADOVA.
Un saggio sul partito armato, sulla
violenza di massa, le notti dei
fuochi e il terrore nelle facoltà.
Uno studio non sociologico, ma
costruito con le sentenze passate in
giudicato emesse dai tribunali, che
in Veneto non hanno mai abdicato al
loro ruolo: Padova fu la capitale
del terrorismo diffuso, con
Autonomia Operaia Organizzata e i
Collettivi Politici Veneti che hanno
costruito un record unico in Italia.
Solo nel biennio 1977-79 furono
denunciati 708 atti di violenza
eversiva, con 447 attentati, 132
aggressioni a persone e 129 rapine e
devastazioni.